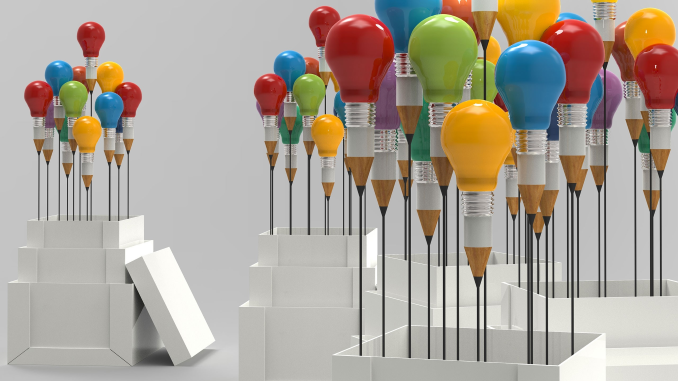Vi proponiamo la traccia di una riflessione proposta da Don Walter Magnoni, responsabile del Servizio per la pastorale sociale e il lavoro nella Diocesi di Milano, al Seminario, in preparazione alla 48ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, che si è svolto a Firenze dal 23 al 25 Febbraio scorsi.
Dello stesso intervento è disponibile anche una registrazione video.
«Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo» (Qo 3,1)
Cosa la Bibbia ci dice circa il lavoro?
Troviamo nel duplice verbo del “coltivare e custodire” il compito che JHWH ci assegna per abitare questa terra. La cura della casa comune chiede un lavoro. Dio stesso lavora per creare la realtà dentro cui siamo. C’è una bellezza da coltivare e custodire. Perché la bellezza educa e l’uomo vive meglio dove anziché degrado vi è ordine, cura e dignità. Vi è anche la fatica e insieme il riposo come momento di sosta per curare le relazioni fondamentale con Dio e con i fratelli.
Se poi spostiamo lo sguardo sul Vangelo c’imbattiamo nella vita nascosta di Gesù a Nazareth di cui abbiamo pochi indizi ma che ha generato tutta una tradizione spirituale che trova tra i suoi esponenti più significativi Charles de Foucauld. Lo stile del lavoro quotidiano fatto anche di lavori umili a contatto coi poveri.
La Bibbia ci parla di uomini che lavorano la terra, che vivono la pastorizia, che costruiscono la città, che lavorano con le loro mani, che commerciano e che fanno strade. Gesù stesso usa esempi presi dal mondo del lavoro e ci provoca con parabole che appaiono paradossali come quella dei lavoratori dell’ultima ora pagati come quelli che hanno faticato tutto il giorno.
In questo tempo risuona in noi quel passo della Bibbia di quella parabola, quella loro parola che ci provoca: «nessuno ci ha presi a giornata».
Cosa dice a noi cristiani questa situazione? Lascio la parola a don Paolo Asolan «Sarebbe facile ridurre la questione del rapporto tra Comunità cristiana e lavoro ad un’esortazione – più o meno preoccupata ed urgente – a muoversi sul piano delle cose da fare. Occorre dire che si tratta comunque di un livello senz’altro necessario: senza le opere, la fede è morta in se stessa. Una pastorale che di fronte alle percentuali di disoccupazione specialmente giovanile si girasse dall’altra parte e proponesse soltanto lectio divine e Grest, avrebbe qualcosa del sacerdote e del levita della parabola.
C’è un precedente storico positivo: all’indomani della pubblicazione di Rerum Novarum vi fu una (benedetta) reazione pastorale che organizzò sul territorio delle diocesi una rete di Casse di risparmio, cooperative, giornali, Sindacati, Leghe bianche… che contribuirono ad affrontare (in altri casi ad avviare processi di soluzione) i problemi legati alla questione sociale, operaia o contadina che fosse.
Sia l’enciclica che il movimento sociale da essa suscitato iniziarono a ricucire uno strappo tra la fede creduta (espressa solitamente nei documenti magisteriali) e la fede vissuta (la prassi pastorale, centrata ancora sul trinomio intra-ecclesiale catechismo/liturgia/carità), integrando una questione che secondo quel trinomio non toccava di per sé l’interesse pastorale, ma che in realtà decideva eccome della vita del popolo di Dio. Papa Leone superò un’idea di magistero ecclesiale preoccupato unicamente di questioni interne alla fede della Chiesa, firmando un’enciclica che di fatto provocò anche in alcuni ambienti cattolici “una certa impressione di sgomento, anzi di molestia e per taluni anche di scandalo” (Pio XI, Quadragesimo Anno, n. 14).
Dunque, lo studio delle buone pratiche e l’impegno concreto per il lavoro ha bisogno di essere incorniciato in una conversione pastorale più ampia, che riveda e ricomprenda meglio quale sia la missione della Chiesa, che non deve essere solo intra-ecclesiale, e che non scinda tra loro fede e questioni di vita quotidiana (come se la relazione a Dio e la fede fossero estrinseche, da aggiungere in un secondo momento, e non aiutassero a riconoscere il Fondamento del reale e il significato delle cose – così necessario per agire), economia della creazione ed economia della redenzione (come se la cura del mondo creato e del lavoro non dipendessero dall’atto creatore del Padre, e non costituissero una via di salvezza)»[1].
Vorrei inserire questo primo affondo in dialogo con la realtà dentro cui siamo immersi. Come cittadini siamo in un mondo dove vi sono almeno due modi di affrontare il lavoro per nulla in sintonia con la visione teologica:
- Anzitutto quella che si potrebbe declinare col seguente slogan: fare tutto quanto è in nostro potere per faticare il meno possibile. Si parte dall’idea che purtroppo si deve lavorare, anche se la vita, quella vera, è altrove. Dietro a questo modo di pensare troviamo persone che entrano nel mondo del lavoro senza passione e grandi interessi, ma con la rassegnazione che per vivere si deve lavorare. Chi ragiona così ha spesso un sogno: vincere qualche grande lotteria per non lavorare più. Insomma, il vizio di fondo è la scissione tra lavoro e vita.
- La seconda visione del lavoro, altrettanto problematica, la declino col motto: vivo per lavorare. Esistono persone che, quando sono in ferie, affrontano questo tempo con difficoltà. La cosa, che di primo acchito potrebbe apparire paradossale, si verifica laddove si fa diventare il lavoro un idolo. Per qualcuno l’attività lavorativa è luogo dove si proiettano tutte le proprie energie migliori perché rapiti dal sogno del successo attraverso l’affermazione professionale e della conseguente ricchezza. Questo porta giovani (rampanti) a sacrificare tutto (famiglia, amici, affetti, Dio) per il mito del lavoro. Insomma, se nel primo caso abbiamo parlato di scissione tra lavoro e vita, qui si realizza una totale sovrapposizione: la vita diventa il lavoro.
Giovanni Paolo II nella Laborem Exercens ci aiuta a uscire da questo duplice rischio con le sue parole a tutti note, ma che è bene ridirci: «Il primo fondamento del valore del lavoro è l’uomo stesso […] per quanto sia una verità che l’uomo è destinato ed è chiamato al lavoro, però prima di tutto il lavoro è “per l’uomo”, e non l’uomo “per il lavoro”» (n. 6).
Se il lavoro è per l’uomo, la domanda diviene: quale metodo accogliere per accompagnare il lavoro in questo tempo?
Qui lascio ancora la parola a don Asolan: il teologo del Laterano mette in guardia dai modelli pastorali deduttivi «dove si ribatte unicamente il dato creduto, reputando che poi la prassi sia una facile esecuzione/applicazione: come se la vita e la prassi non funzionassero già secondo intenzionalità proprie, magari implicite». Ma al contempo anche quelli induttivi hanno dei limiti perché «si pretende che una buona esperienza valga come legge universale dell’azione: come se in contesti diversi potessero valere le medesime soluzioni, e come se la fede e la redenzione di Cristo fossero uno sviluppo organico della vita sociale, che non avrebbe bisogno di annuncio e di vita ecclesiale.
Vanno tenuti in reciprocità dialettica il dato di fede e il dato del contesto.
Vale, per questo, il metodo del discernimento: la luce della Rivelazione in Cristo accolta e mantenuta in tutto il suo splendore aiuta a riconoscere la presenza di Cristo stesso nella storia che viviamo e nei fenomeni che la segnano, e ad assecondarne l’azione per la salvezza del mondo e nostra. È il metodo della Teologia pastorale, di quella scienza che risponde alla domanda “che cosa la Chiesa deve fare qui e ora?”.
Occorrerà prepararsi forse di più, ed esercitarsi forse di più nell’acquisire questo metodo: per non cadere in nuovi dogmatismi (diversi dai vecchi centrati sulla dottrina, anche sulla Dottrina sociale della Chiesa) centrati sulle ideologie; o in nuovi induttivismi, dove il valore di quel che si fa viene fatto coincidere soltanto con la sua efficacia di funzionamento o il suo consenso nell’opinione pubblica.
Dovremo sempre più fare i conti con il compito di formare e sostenere coscienze di cristiani capaci di discernimento, e perciò di presa d’iniziativa e di testimonianza.
Una certa formazione alla pastorale sociale si è forse troppo velocemente fermata alla conoscenza dei documenti e dei principi, alle scuole di Dottrina sociale. In questo senso, l’aggiornamento che l’Ufficio nazionale propone va verificato e sostenuto anche nelle diocesi, dove occorrerà tenere meglio in conto le storie proprie a ciascuna comunità: l’adesione al reale di quelle storie e di quelle identità è la prima fedeltà alla missione che ci è richiesta. Non esiste una pastorale sociale ideale: esiste quella possibile a noi lì dove siamo, senza confronti indebiti con contesti e identità diverse. Il confronto può aiutare, ma può anche inibire e sterilizzare».
Credo che i “cercatori di LavOro” vadano posti dentro questa dimensione: prassi che ci fanno pensare, ci suggeriscono percorsi da porre dentro la storia del territorio dove noi siamo posti. Ma lo stile di fondo lo direi così: esserci con tutto noi stessi per fare bene il bene.
Di sicuro lo stile fondamentale, senza il quale non si è efficaci è quello di esserci con tutto se stessi. Nel senso che non basta la presenza fisica. Infatti, così come non è sufficiente allo studente recarsi a scuola per espletare pienamente il suo compito, ma gli è richiesto di ascoltare quanto viene detto, al contrario sarebbe lì solo a “scaldare il banco”, allo stesso modo, chi lavora deve esser presente con tutto se stesso, anche perché in alcuni lavori le distrazioni possono provocare gravi danni fisici a sé e agli altri.
La nostra società, attraverso le nuove tecnologie, non sempre aiuta questo stile di concentrazione che porta ad essere pienamente presenti laddove si è. Penso a chi studia col cellulare sul banco, il computer acceso e connesso a internet. Quante volte s’interrompe lo studio per “chattare” su Facebook o rispondere agli amici che scrivono compulsivamente su WhatsApp? Tutto questo produce dispersione e non aiuta l’attività principale che si sta svolgendo in quel momento.
In realtà, tutto quello che si è detto finora chiede di essere giustificato alla sua radice e per tale ragione vanno affrontate due domande che divengono cruciali.
La spiritualità monastica ha un motto: Age quod agis.
La dispersione si supera stando con tutto se stessi dove si è. Questo lavoro che chiede disciplina, diviene fondamentale oggi.
«Cosa c’entra il lavoro con la spiritualità?». Per rispondere dobbiamo scrutare i primi capitoli della Bibbia, precisamente i primi undici capitoli di Genesi, dove gli esegeti ci dicono che la storia dell’uomo di sempre è riportata alle origini.
Qui troviamo un passaggio illuminante: «II Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen 2, 15). All’uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio, è dato il compito di prendersi cura di quel giardino che è il mondo intero. Da tali parole si comprende come il lavoro sia vocazione per chi crede nel Dio che crea il mondo e lo mette al centro del cosmo per migliorarlo attraverso l’attività di ogni giorno. Gesù stesso nelle sue parabole benedice l’operosità delle persone, richiamandole alla responsabilità. Si pensi alla parabola dei talenti: a ciascuno è dato qualcosa perché lo faccia fruttificare e il servo “pigro” viene gettato fuori e non prende parte alla gioia del suo padrone come gli altri (cfr. Mt 25, 14-30).
Uno dei compiti fondamentali dell’educazione cristiana è quello di aiutare le persone a comprendere lo stretto nesso tra fede e vita. L’incontro col Signore e il suo Vangelo permea tutta la vita dell’uomo in ogni sua dimensione e quindi anche quella del lavoro. Si deve evitare la separazione tra la propria vita cultuale, fatta di preghiera e pratica dei sacramenti e il resto delle attività. La spiritualità del lavoro è precisamente il credere che lo Spirito santo guida l’azione delle persone dando loro un’impronta cristiana in ogni attività svolta e quindi anche all’interno di quella lavorativa o di studio per chi ancora non lavora.
Infine, mi piace ricordare l’esempio dei benedettini presente nella Laudato si’ quando si affronta la questione lavorativa: «Raccogliamo anche qualcosa dalla lunga tradizione monastica. All’inizio essa favorì in un certo modo la fuga dal mondo, tentando di allontanarsi dalla decadenza urbana. Per questo i monaci cercavano il deserto, convinti che fosse il luogo adatto per riconoscere la presenza di Dio.
Successivamente, san Benedetto da Norcia volle che i suoi monaci vivessero in comunità, unendo la preghiera e lo studio con il lavoro manuale (Ora et labora). Questa introduzione del lavoro manuale intriso di senso spirituale si rivelò rivoluzionaria. Si imparò a cercare la maturazione e la santificazione nell’intreccio tra il raccoglimento e il lavoro. Tale maniera di vivere il lavoro ci rende più capaci di cura e di rispetto verso l’ambiente, impregna di sana sobrietà la nostra relazione con il mondo» (126).
Queste ultime parole sono l’augurio per una spiritualità del lavoro dove il lavoro, la preghiera e lo studio si armonizzano in una vita ordinata e santa.
Bellezza, fatica e riposo, lavoro insieme sono le vie che la storia della spiritualità consegna a noi ancora oggi e sui quali si gioca il nostro approccio al lavoro.
Anche il lavoro sta nelle cose penultime, ma senza lavoro la vita perde di senso e sostenere il senso della vita è fondamentale onde evitare un degrado culturale, sociale e della polis.
Da questa affermazione scaturisce la seconda domanda: «Quale stile dovrebbe avere un cristiano sul posto di lavoro?». Anche in questo caso esistono due estremi da evitare. II primo lo declino con uno slogan: la fede è mia e me la gestisco io. È l’atteggiamento di chi sul lavoro evita assolutamente di far trasparire la propria fede, sia per timore che questa possa danneggiarlo, sia per timidezza, sia per l’errata convinzione che non sia argomento che deve trapelare in ambito lavorativo.
AI contrario, ci sono quelli che ostentano la fede e si credono i salvatori del mondo, dimenticando che vi è un solo Salvatore e che quando è venuto ha avuto un profondo rispetto della libertà degli uomini e delle donne che ha incontrato sul suo cammino. Ancora una volta, lo stile passa da una presenza discreta che, senza ostentare, non si sottrae al confronto su tutto e quindi anche sul proprio credo. Ma, soprattutto, il cristiano è chiamato attraverso il suo vivere a testimoniare nei fatti ciò in cui crede. Saper ascoltare le persone, esercitare la discrezione, fare bene le proprie mansioni (semplici o complicate che siano), vivere la solidarietà e porre segni di gratuità: sono tutti gesti non scontati che dicono di uno stile simile a quello che troviamo in Gesù nel suo Vangelo. Anzitutto, si tratta di accorgersi degli altri, che siano colleghi o persone con le quali si entra in contatto a causa del tipo di lavoro che si svolge. In secondo luogo, ci è chiesto di non cadere nei pettegolezzi o in quella che nella Bibbia prende il nome di “mormorazione”. Aspetto centrale è l’essere responsabili e far bene le mansioni richieste.
Un altro aspetto, oggi troppe volte disatteso, è il recupero dei legami di solidarietà e gratuità coi colleghi di lavoro e con chi è senza lavoro. Un tempo se un lavoratore veniva licenziato, quelli che condividevano con lui quell’attività si coalizzavano e verificavano – nei limiti del possibile – che non vi fossero ingiustizie. Vi è stata una stagione in cui i lavoratori sentivano con forza il loro legame. Oggi, in un’epoca sempre più segnata dall’individualismo, questi tipi di legami si sono indeboliti e il segno più eloquente è lo scarso ricorso ai “contratti di solidarietà” che consentono ai lavoratori delle ditte in crisi di lavorare un po’ tutti, anche se meno. Non può un cristiano, di fronte al collega licenziato, uscire con affermazioni del tipo: «per fortuna non è toccato a me».
Dobbiamo sentirci coinvolti tutti nel sostenere chi non ha lavoro. Cosa posso fare oggi? È il tema del lavOro… Ma penso sia utile lasciare ancora la parola a Paolo Asolan che ci esorta con queste parole: «Giustamente l’obiettivo della giornata parla di “affinare i criteri di riconoscimento”: i criteri non sono dati una volta per sempre (come i principi, che sono assoluti – non dipendono, cioè, dalla situazione), ma vanno elaborati facendo reagire tra loro il dato di fede e il dato della situazione e del contesto.
E questo in vista dell’azione: per agire, non per fermarsi alle diagnosi, ai best practice, alla testimonianza riuscita degli altri, e neppure alle nostre impossibilità. […] La crisi economica, occupazionale e sociale nella quale ci troviamo è chiaramente un segno dei tempi, che chiede impegno concreto non meno che la messa a punto di criteri di interpretazione di fede che ispirino lo stesso impegno.
Questo compito ha da essere assunto dalle comunità cristiane anche qualora non avessero mezzi o capacità per impegnarsi direttamente nella creazione di posti di lavoro, o non avessero risorse per potersi impegnare nel sostegno delle situazioni critiche.
C’è, infatti, un servizio che anche la più malmessa delle parrocchie può offrire, ed è il lavoro per una conversione delle mentalità che recuperi o comunque investa nella formazione. Dopo alterne fasi progressive e drammatiche di separazione tra fede e cultura, si profila per la Comunità cristiana l’opportunità storica dell’assunzione di un compito decisivo per il suo futuro e per il futuro della società: l’assunzione di un orizzonte e di un quadro prospettico, che (finalmente!) non si limita a reagire ai fenomeni socioculturali, ma intende inserirsi in maniera efficace, competente e rispettosa, nei processi che presiedono al loro formarsi e affermarsi nella società».
Una teologia in dialogo col magistero
Vorrei aggiungere a queste osservazioni le indicazioni significative che sono offerte dal Magistero di Papa Francesco. Cosa suggerisce il Papa argentino al nostro approccio al lavoro?
Nella Esortazione apostolica Evangelii Gaudium troviamo «quattro principi che orientano specificamente lo sviluppo della convivenza sociale» (221) e che vorrei poter applicare in relazione alla vita di un giovane che inizia a lavorare.
- Il tempo è superiore allo spazio. «Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone» (EG 223). Il Pontefice ha in mente soprattutto quel modo di fare politica tentato di privilegiare gli spazi di potere piuttosto che i tempi dei processi. Ma pensando a un giovane che entra nel mondo del lavoro, sento la necessità di segnalare la pertinenza di questo principio in relazione alla possibile creazione di nuove start-up. La narrazione di giovani “vincenti” che dal nulla hanno costruito un impero economico cavalcando semplicemente un’idea vincente, va messa in relazione alla storia di tante start-up fallite con dispendi economici e scoraggiamenti. Immaginarsi imprenditori di se stessi è in sé qualcosa di positivo, ma non basta lo spazio di un’idea per buttarsi in un’impresa nuova. Decisivo appare il confronto con persone che conoscono i processi economici e sono in grado di vedere se l’intuizione potrà resistere alla prova del tempo.
- L’unità prevale sul conflitto. Anche il mondo del lavoro è abitato da conflitti, anzi è uno dei luoghi dove il conflitto è la regola. Vivere in modo positivo il conflitto è arte tutta d’apprendere e dove lo stile del cristiano può dire qualcosa a tutti. Significa non cedere alla logica dell’arrivismo che schiaccia i colleghi, non cadere nella pratica sterile del pettegolezzo sugli assenti, lavorare bene con i compagni di lavoro, praticare la solidarietà e capire che la qualità relazionale è la vera chiave con cui affrontare oggi il nostro impegno quotidiano. Nelle situazioni di crisi talvolta i lavoratori si spaccano perché non prevale la logica del bene comune ma quella dell’interesse individuale. Essere uomini e donne di unità nei luoghi di lavoro ha un valore inestimabile ed è per questo che quanto detto in precedenza sul tema della solidarietà e della gratuità si applica pienamente a questo principio.
- La realtà è più importante dell’idea. Per spiegare meglio questo principio Francesco afferma: «Ciò che coinvolge è la realtà illuminata dal ragionamento. Bisogna passare dal nominalismo formale all’oggettività armoniosa. Diversamente si manipola la verità, così come si sostituisce la ginnastica con la cosmesi» (EG 232). Serve un grande realismo per cogliere i cambiamenti in atto nel mondo del lavoro. La cosiddetta “Industria 4.0” è già realtà. Dopo la rivoluzione del carbone e della macchina a vapore; dopo quella del petrolio, dell’energia elettrica e della produzione di massa; e dopo quella più recente di internet e delle tecnologie dell’informazione e dell’automazione, oggi siamo nel campo dell’intelligenza artificiale (ovvero macchine capaci d’apprendere), della stampa 3D, delle nanotecnologie e delle biotecnologie. È con questa realtà che ci dobbiamo misurare senza paura, ma col realismo di chi sa che solo un’intelligenza non rigida sarà in grado di scorgere le nuove opportunità lavorative che si aprono a fronte di quelle che vanno ad esaurirsi.
- Il tutto è superiore alla parte. È la grande sfida, che copre anche il mondo della produzione, tra locale e globale. Con la globalizzazione (di cui Papa Benedetto XVI ci ha offerto un’analisi lungimirante nella Caritas in veritate) il mondo si è fatto più piccolo e le interazioni sono aumentate esponenzialmente. Chi entra oggi nel mondo del lavoro deve avere uno sguardo ampio e capace di cogliere non solo i limiti della globalizzazione, ma soprattutto le opportunità. La conoscenza di altre lingue, oltre all’italiano, è sempre più uno strumento essenziale per non rimanere isolati dal resto del Pianeta. Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più ampia: mi pare questo lo stile suggerito dal Pontefice in questo punto.
Il modello non è la sfera ma il poliedro: vorremmo che tutto fosse ordinato e chiaro, ma viviamo la tensione dell’impotenza del generare lavoro, di giovani disoccupati, di aziende che chiudono e altre che nascono. Il poliedro ci mostra la complessità che va abitata ed è il compito che la teologia e il magistero affidano alla società e alla chiesa tutta.
Concludo citando una pagina di vangelo che mi è cara; quella dove Gesù parla della campagna di un uomo che aveva dato un buon raccolto. Costui di fronte all’abbondanza di doni immagina un futuro di rendita fatto di nuovi granai che gli permetteranno di gustarsi la vita. Ma Gesù aggiunge: stolto! Questa notte ti sarà chiesta la vita e ciò che hai accumulato di chi sarà? Così è per chi accumula per sé e non arricchisce davanti a Dio.
È una parabola che apre all’interrogativo tra lavoro e uso delle risorse. È una questione che interpella anche la chiesa e i cristiani e sfida tutti noi a pensare a come usiamo delle ricchezze che ci sono affidate.
____________________________________________________________________________
[1] Ho messo tra virgolette questa citazione in quanto presa da uno scritto di don Paolo Asolan pensato per questa giornata. Don Paolo non ha potuto essere presente in quanto ammalato, ma credo che sia corretto recuperare almeno parzialmente le sue riflessioni.