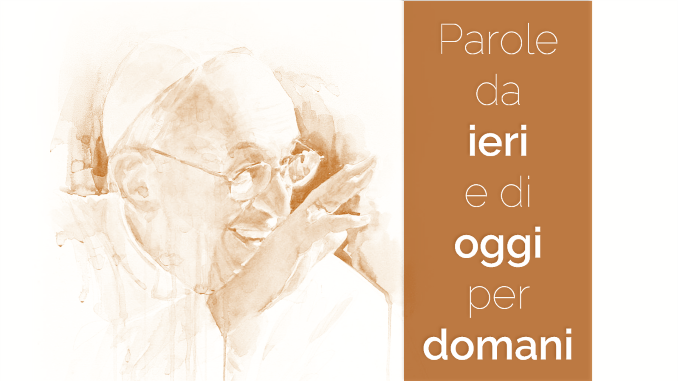Pubblichiamo un brano del libro “Ritorniamo a sognare” (Piemme) scritto dal Pontefice con il giornalista Austen Ivereigh, in libreria da dicembre. Il brano è stato anticipato dal quotidiano la Repubblica nell’edizione in edicola lo scorso 23 novembre.
Quando a ventun anni ho contratto una grave malattia, ho avuto la mia prima esperienza del limite, del dolore e della solitudine. Mi ha cambiato le coordinate. Per mesi non ho saputo chi ero, se sarei morto o vissuto. Nemmeno i medici sapevano se ce l’avrei fatta. Ricordo che un giorno chiesi a mia madre, abbracciandola, di dirmi se stavo per morire. Frequentavo il secondo anno del seminario diocesano a Buenos Aires.
Ricordo la data: era il 13 agosto 1957. A portarmi in ospedale fu un prefetto, accortosi che non avevo il tipo di influenza che si cura con l’aspirina. Per prima cosa mi estrassero un litro e mezzo di acqua da un polmone, poi restai a lottare tra la vita e la morte. A novembre mi operarono per togliermi il lobo superiore destro del polmone. So per esperienza come si sentono i malati di coronavirus che combattono per respirare attaccati a un ventilatore.
Di quei giorni ricordo in particolare due infermiere. Una era la caposala, una suora domenicana che prima di essere inviata a Buenos Aires era stata docente ad Atene. Ho saputo in seguito come, dopo che il medico se ne andò una volta concluso il primo esame, sia stata lei a dire alle infermiere di raddoppiare la dose del trattamento che lui aveva prescritto – a base di penicillina e di streptomicina – perché la sua esperienza le diceva che stavo morendo. Suor Cornelia Caraglio mi salvò la vita. Grazie al suo contatto abituale con i malati, conosceva meglio del medico ciò di cui avevano bisogno i pazienti, ed ebbe il coraggio di usare quell’esperienza.
Un’altra infermiera, Micaela, fece la stessa cosa quando ero straziato dal dolore. Mi dava in segreto dosi extra di calmanti, fuori dell’orario previsto. Cornelia e Micaela ormai sono in cielo, ma sarò sempre in debito con loro. Si sono battute per me fino alla fine, finché non mi sono ripreso. Mi hanno insegnato che cosa significa usare la scienza e sapere andare anche oltre, per rispondere alle necessità specifiche.
Da quella esperienza ho imparato un’altra cosa: quanto sia importante evitare la consolazione a buon mercato. Le persone mi venivano a trovare e mi dicevano che sarei stato bene, che non avrei mai più provato tutto quel dolore: sciocchezze, parole vuote dette con buone intenzioni, ma che non mi sono mai arrivate al cuore. La persona che più mi ha toccato nell’intimo, con il suo silenzio, è stata una delle donne che mi hanno segnato la vita: suor María Dolores Tortolo, mia insegnante da piccolo, che mi aveva preparato per la Prima Comunione. Venne a vedermi, mi prese per mano, mi diede un bacio e se ne stette zitta per un bel po’. Poi mi disse: «Stai imitando Gesù». Non c’era bisogno che aggiungesse altro. La sua presenza, il suo silenzio, mi donarono una profonda consolazione.
Dopo quell’esperienza presi la decisione di parlare il meno possibile quando visito malati. Mi limito a prendergli la mano.
[…]
Potrei dire che il periodo tedesco, nel 1986, è stato il “Covid dell’esilio”. Fu un esilio volontario, perché ci andai per studiare la lingua e a cercare il materiale per concludere la mia tesi, ma mi sentivo come un pesce fuor d’acqua. Scappavo a fare qualche passeggiatina verso il cimitero di Francoforte e da lì si vedevano decollare e atterrare gli aeroplani; avevo nostalgia della mia patria, di tornare. Ricordo il giorno in cui l’Argentina vinse i Mondiali. Non avevo voluto vedere la partita e seppi che avevamo vinto solo l’indomani, leggendolo sul giornale. Nella mia classe di tedesco nessuno ne fece parola, ma quando una ragazza giapponese scrisse «Viva l’Argentina» sulla lavagna, gli altri si misero a ridere. Entrò la professoressa, disse di cancellarla e chiuse l’argomento.
Era la solitudine di una vittoria da solo, perché non c’era nessuno a condividerla; la solitudine di non appartenere, che ti fa estraneo. Ti tolgono da dove sei e ti mettono in un posto che non conosci, e in quel mentre impari che cosa conta davvero nel luogo che hai lasciato.
A volte lo sradicamento può essere una guarigione o una trasformazione radicale. Così è stato il mio terzo “Covid”, quando mi mandarono a Córdoba dal 1990 al 1992. La radice di questo periodo risaliva al mio modo di comandare, prima da provinciale e poi da rettore. Qualcosa di buono senz’altro lo avevo fatto, ma a volte ero stato molto duro. A Córdoba mi hanno reso il favore e avevano ragione.
In quella residenza gesuita trascorsi un anno, dieci mesi e tredici giorni. Celebravo la Messa, confessavo e offrivo direzione spirituale, ma non uscivo mai, se non quando dovevo andare all’ufficio postale. Fu una specie di quarantena, di isolamento, come nei mesi scorsi è successo a tanti di noi, e mi fece bene. Mi portò a maturare idee: scrissi e pregai molto.
Fino a quel momento nella Compagnia avevo avuto una vita ordinata, impostata sulla mia esperienza dapprima da maestro dei novizi e poi di governo dal 1973, quando ero stato nominato provinciale, al 1986, quando conclusi il mio mandato di rettore. Mi ero accomodato in quel modo di vivere. Uno sradicamento di quel tipo, con cui ti spediscono in un angolo sperduto e ti mettono a fare il supplente, sconvolge tutto. Le tue abitudini, i riflessi comportamentali, le linee di riferimento anchilosate nel tempo, tutto questo è andato all’aria e devi imparare a vivere da capo, a rimettere insieme l’esistenza.
Di quel periodo, oggi, mi colpiscono in particolare tre cose. Prima, la capacità di pregare che mi è stata donata. Seconda, le tentazioni che ho provato. E terza – ed è la cosa più strana – che allora mi sia capitato di leggere i trentasette tomi della Storia dei Papi di Ludwig Pastor. Avrei potuto scegliere un romanzo, qualcosa di più interessante. Da dove sono adesso mi domando perché Dio mi avrà ispirato a leggere proprio quell’opera in quel momento. Con quel vaccino il Signore mi ha preparato. Una volta che conosci quella storia, non c’è molto che possa sorprenderti di quanto accade nella curia romana e nella Chiesa di oggi. Mi è servito molto!
Il “Covid” di Córdoba è stato una vera purificazione. Mi ha dato più tolleranza, comprensione, capacità di perdonare. Mi ha lasciato anche un’empatia nuova con i deboli e gli indifesi. E pazienza, molta pazienza, ovvero il dono di capire che per le cose importanti ci vuole tempo, che il cambiamento è organico, che ci sono limiti e dobbiamo operare al loro interno e mantenere al tempo stesso gli occhi sull’orizzonte, come ha fatto Gesù. Ho imparato l’importanza di vedere il grande nel piccolo, e di stare attento al piccolo nelle cose grandi. È stato un periodo di crescita in molti sensi, come tornare a germogliare dopo una potatura a fondo.
Ma devo stare in guardia, perché quando cadi in certi difetti, in certi peccati, e ti correggi, il diavolo, come dice Gesù, torna, vede la casa «spazzata e adorna» (Luca 11, 25) e va a chiamare altri sette spiriti peggiori di lui. La fine di quell’uomo, dice Gesù, diventa molto peggiore di prima. Di questo devo preoccuparmi, adesso, nel mio incarico di governare la Chiesa: di non cadere negli stessi difetti di quando ero superiore religioso.
[…] Questi sono stati i miei principali “Covid” personali. Ne ho imparato che soffri molto, ma se lasci che ti cambi ne esci migliore. Se invece alzi le barricate, ne esci peggiore.