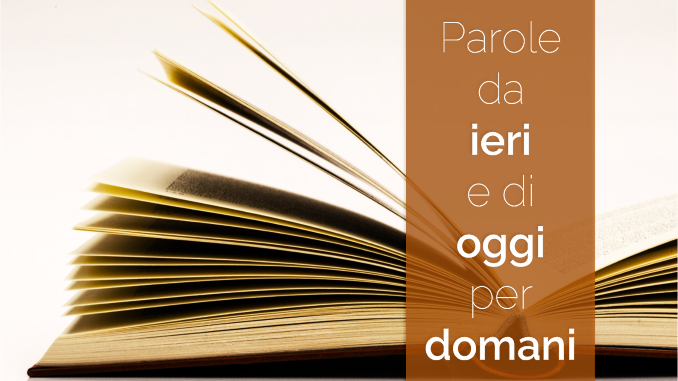(di Marco Dotti)
Il fatto che il presente ci appaia senza vie di uscita può dipendere da due condizioni concomitanti. La prima è che derivi da una nostra analisi lacunosa: ci mancano gli strumenti per un attraversamento ermeneutico forte del frangente spazio-temporale che siamo chiamati a vivere.
La seconda è che siano mutate le qualità specifiche del territorio da attraversare, quel territorio che definiamo, appunto, “il nostro tempo”.
La sensazione è che le connessioni fra i tanti nodi che siamo letteralmente si sfilino, man mano che si faccia appello alla loro concretezza, sotto i nostri stessi piedi, rendendo impossibile ogni attraversamento. Non abbiamo una mappa. Ma, soprattutto, non abbiamo più un territorio.
Nella networked society scopriamo di essere paradossalmente (nodi) senza rete. Alle reti e alla mediazione dei corpi intermedi, tradizionali tessitori in una società organizzata (anche) verticalmente, si è sostituita una rapidissima disintermediazione, con una perdita di complessità e una radicale, ma regressiva riconfigurazione del capitale sociale. Un capitale sociale che continuiamo però a imputare alla prima (alla società dei corpi intermedi), ma che di fatto non le appartiene più.
La politica, in questo gioco, sembra ridursi a una paradossale post-politica (post-political politics) e opera in tale contesto come un grafo: attrice di verticalizzazioni estemporanee quanto a manifestazione, effimere quanto a tenuta. Un grafo è, tecnicamente, un sistema semplice di nodi collegati da legami deboli e, in questo caso, episodici. Legami che, appunto, non “fanno rete”. Tutto si risolve nel privato e in forme di esplosione estemporanea, sorta di “ammutinamenti elettorali” senza progetto che costituiscono l’unica intersezione possibile in uno spazio che si definisce “comune” solo in virtù di quelle esplosioni.
Convergenze austere
La crisi del paradigma locale-globale descritta da Bruno Latour, unita alla tendenza alla “destrizzazione del mondo” (droitisation du monde), dopo aver liquidato la seconda, confinandola in una protesta sostanzialmente sterile, sembra aver messo definitivamente fine a ogni terza via.
Convivono ora sullo stesso piano una forte gestione dell’aggressività e una altrettanto forte tendenza all’omologazione: cose che vanno assieme, nel momento in cui esistono condizioni che permettono all’aggressività di manifestarsi e all’omologazione di espandersi. L’affacciarsi sulla scena del presente di queste condizioni è ciò che disorienta. Ma è anche la cifra attraverso la quale leggere l’efficacia di medio e forse lungo periodo dei cosiddetti “populismi” e di quel fenomeno così complessivo e radicale che sempre più assume le forme di una secessio plebis dalle forme classiche e persino postmoderne della mediazione e del conflitto.
I modelli di coloro che hanno avuto successo alle ultime elezioni, dal “vaffa” alle varie critiche urlate al mainstream, sono altrettante “scelte di Hobson” caratterizzate non come occasione di promessa elettorale, ma come opportunità di una gratificazione immediata che, in sé, giustifica la spendita di un voto. Al contempo, nel vuoto delle ermeneutiche le retoriche antimmigrazione più che forme di attivazione di rancore, fungono da paradigma offrendo ai più una facile, semplicistica, ma drammaticamente efficace chiave per leggere il nostro tempo ad usum populi.
Lo scambio politico sembra collocarsi a questo grado zero di spesa (un voto) e consumo (un urlo). Un urlo, un voto. E viceversa. La post-politica innesca cerchi concentrici che vanno poi a spegnersi da sé, oramai sganciata com’è da ogni sistema di decisioni reali e completamente disconnessa dai processi attraverso i quali le decisioni concrete sarebbero costrette a confrontarsi.
Dove andiamo
Una recente indagine del Pew Research Center, dedicata alle “Attitudes of Christians in Western Europe”, ha rivelato come anche nei territori della fede si stia consolidando una logica di questo tipo. Una logica da «der eigene Gott», da divinità personale, la stessa di cui ci hanno parlato Beck, Berger, Taylor, etc., individualizzata e individualizzante, innestata sul complessivo depauperamento del capitale sociale, che trasforma anche la “religione” in un altro grafo. Non possiamo illuderci che dall’immenso bacino simbolico del religioso e del sacro, questa post-politica non attinga a piene mani.
Seguendo questa lettura, nelle società post-secolari sembra oramai prevalere un credere senza appartenere. Altrove, in particolare nell’Europa orientale, sembra per contraltare avanzare un appartenere senza credere. Ma il risultato non cambia. All’aspetto intimista del “Dio personale” si unisce, però, quello di una canalizzazione post-politica della rabbia che si serve di alcuni codici e canali simbolici tradizionali per espandersi e radicarsi con più forza.
Il rancore rischia di essere l’unico sentimento socialmente condiviso senza imbarazzo e, così, divenire un rassicurante collante identitario per soggettività sfibrate – anche nella fede. Una sorta di capitale asociale facilmente monetizzabile e pronto all’uso. In ciò che Carl Strenger ha chiamato i commodity market, rientra anche questa forma di pseudo-sacralizzazione del campo post-politico.
Ciò che comunemente, con una semplificazione, chiamiamo populismo è forse solo la prima fase – fase che sta subendo un’accelerazione esponenziale e che, a mio avviso, sul breve periodo, ovvero all’appuntamento elettorale europeo del 2019 presenterà il conto – di tale monetizzazione del rancore. Una fase che, proprio perché può appoggiarsi parassitariamente a codici simbolici di lunga durata, rischia di mettere profonde radici.
E dunque, cosa facciamo?
In un suo scritto civile su “Christianity and Race in the United States”, Thomas Merton avanzava un’ipotesi a suo modo estrema sulle forme di questo sfibramento.
Un’ipotesi racchiusa – ancora una volta – in una domanda: e se il tempo propizio per porsi queste domande fosse già passato? E se fosse già troppo tardi? Chiederselo è un presupposto, per orientare il “che fare” al concreto. Con tutti i rischi che il concreto comporta.
Il dubbio, in ogni caso, è legittimo poiché mentre è sempre più facile agire senza capire in nome di un decisionismo isterico, il “presente”, fra i segni contraddittori che lancia, ne lancia purtroppo alcuni che a prima vista sembrano incontrovertibili: che sia tramontato il tempo del capire per agire, in nome di un riformismo orientato se non proprio all’utopia quanto meno alla comune speranza. Le cose stanno davvero così?
Merton ricordava che il kairos, ovvero il tempo della decisione urgente e provvidenziale, «è qualcosa di caratteristico del cristianesimo, religione di decisioni nel tempo e nella storia». Da qui una questione, che è la stessa da cui siamo partiti: come possiamo, da cristiani, riconoscere il nostro kairos? Come capire che è venuto, se è venuto, il tempo per un’azione inevitabilmente imperfetta e provvisoria, ma altrettanto inevitabilmente decisiva e urgente? Queste domande, oggi, dobbiamo porcele fino in fondo. Senza timore.
Dove siamo
Prima ancora di capire dove andiamo, dobbiamo comprendere dove siamo. Se vogliamo far precedere l’analisi all’azione, non per paralizzare quest’ultima ma per orientarla con metodo, dobbiamo rielaborare codici, parole comuni e un pensiero che sia – mi si passi il termine – più profetico che nostalgico. Come? Intanto cominciamo a porci, in comune, la domanda.
Partire dalle domande e non dalle risposte. Altrimenti passeremo, come scriveva lucidamente l’ultimo Pasolini, dal “che fare?” al “che farci”, con annessa alzata di spalle e perdita dell’interrogazione.
Se il problema risiede in un territorio che non siamo più in grado di controllare, né affrontare – per la conformazione che sembra assumere – servendoci di quei paradigmi di stato che per comodità chiamiamo “mappe”, prima di elaborarne di nuove proviamo a guardarci attorno, rasoterra.
Ritengo sia questo un nodo tematico-problematico preliminare su cui potremmo concentrare prima facie la nostra attenzione. Ponendo e ponendoci la domanda: “dove siamo?” implicitamente ci apriamo a quello stupore che, nel suo celebre Coloquio de los perros, Cervantes descrive come il dissodamento inaspettato di un imprevisto terreno comune ad opera della parola.
Come nodi senza rete la domanda potrebbe non avere senso alcuno e il presente apparire, inevitabilmente, senza vie d’uscita. Come nodi in cerca di una rete (il «non a sinistra, né a destra ma in alto» di don Mazzolari), forse tutta da costruire, può averne. E non è poco. Forse il kairos cui faceva cenno Merton, oggi, altro non è che la concreta speranza che, come per Cipión e Berganza della novella esemplare del Cervantes, la parola, fra noi, in qualche modo accada e qualcosa sia ancora possibile.
Iniziando semplicemente a parlare forse ci ritroveremo, come invitava a fare il nostro Edoardo Caprino, un po’ più liberi e un po’ più forti, ma di sicuro e di gran lunga meno soli. E, così facendo, forse avremo posto i primi mattoni per costruire, con umiltà, una rete. Magari partendo da uno specifico territori, delimitato e circoscritto (una diocesi?), dove provare a sperimentare, prima ancora che costruire, un modello di relazione-azione che, in qualche modo, vada oltre le continue polarizzazioni amico-nemico (inimicus più che hostis), entrambe apparenti, là dove, alternativamente, idealizzate o stigmatizzate) in cui la cronaca politica, giorno dopo giorno, riduce il nostro campo visivo e paralizza la nostra comprensione non meno della nostra azione.
(da www.generativita.it)