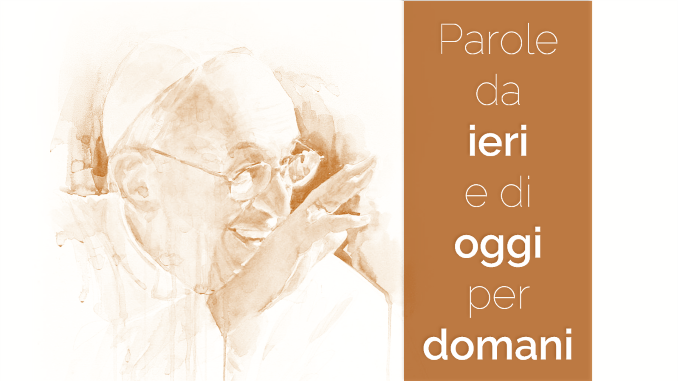L’impennata delle vittime sul luogo di lavoro non è una fatalità ma la conseguenza della precarizzazione e della flessibilità. Occorrono investimenti e maggiori ispezioni, ma serve un radicale cambio di sistema se si vuole fermare la strage.
di Stefano Biondi*
È inaccettabile il modo che normalmente si usa per affrontare il problema dei morti sul lavoro. Il contatore è arrivato a 599 vittime dall’inizio dell’anno, ma il numero è purtroppo in continua crescita. Si nota, tra l’altro, una certa assuefazione nell’opinione pubblica. Quasi che, i singoli episodi, siano dovuti ad un ineluttabilità del destino.
La questione è quasi sempre affrontata in termini statistici, come fosse un andamento dei consumi, quasi un deprecabile effetto collaterale dello sviluppo da ridurre il più possibile con interventi legislativi e con tecniche di sicurezza e di prevenzione. Quest’ultime, ovviamente, sono assolutamente indispensabili e sono il minimo eticamente decente che un Paese cosiddetto civile deve fare.
Si fanno valutazioni in base alle percentuali riferite agli anni precedenti e basta uno scostamento percentuale in meno per dire che stiamo migliorando. Senza dire però che anche una sola morte per causa di lavoro è inaccettabile. È un problema grave che investe la coscienza profonda, personale e collettiva insieme.
Fino a qualche anno fa queste vittime venivano chiamate morti bianche, oggi invece si parla, in modo quasi asettico, incidente mortale sul lavoro: appunto è derubricato ad incidente, mentre è un fatto endemico e costitutivo dell’attuale modello di sviluppo.

Da parte mia preferisco il termine di “caduti sul lavoro”. Ricorda una guerra perché di guerra si tratta e come in ogni guerra sono soprattutto gli ultimi a pagare il prezzo più alto: è anche un forte indicatore di classe sociale.
Nel conteggio bisogna far rientrare anche le vittime di malattie professionali o di incidenti stradali avvenuti nel percorso da casa per il lavoro e ritorno. E poi rientrano, a ben vedere, anche le vittime “civili”, senza numero, prodotte dagli effetti tossici dell’inquinamento prodotto nel mondo dalle attività industriali.
Ma anche considerando solo le stime per eventi causati dallo svolgimento di attività lavorative, le cifre (dati ILO) sono terribili e ci dicono che ogni anno nel mondo muoiono sul lavoro 2,78 milioni di persone per “incidenti” (400mila) o per malattie connesse con l’attività lavorativa (2,4 milioni), mentre circa 160 milioni contraggono malattie o infermità permanenti.
La questione è certamente molto complessa, ma si tratta di vittime sacrificali offerte all’idolo della ricerca del profitto ad ogni costo, con la competizione esasperata che produce scarti di ogni tipo, umani e non.
Nei processi di flessibilizzazione e precarizzazione del rapporto di lavoro si nasconde spesso un pesante ricatto sul lavoro stesso anche per gli aspetti legati alla sicurezza. È evidente, in tal senso, l’impennata dei dati del 12,5% avvenuta in Italia dal 2013 al 2014 e cioè dopo l’introduzione del Jobs Act.
Questa è l’economia che uccide di cui parla papa Francesco e questa consapevolezza chiede che si metta in discussione profondamente l’organizzazione economica e della produzione. Occorre cambiare paradigma, qui sta la vera soluzione. Certo, nel frattempo, con urgenza, occorre operare per reprimere e contenere il fenomeno e i suoi effetti, fare di più tutto quello che può incidere per salvaguardare l’integrità dei lavoratori, ma anche quella delle comunità che vivono intorno agli insediamenti industriali.
Continua a leggere su www.cittanuova.it
* Responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di Pisa