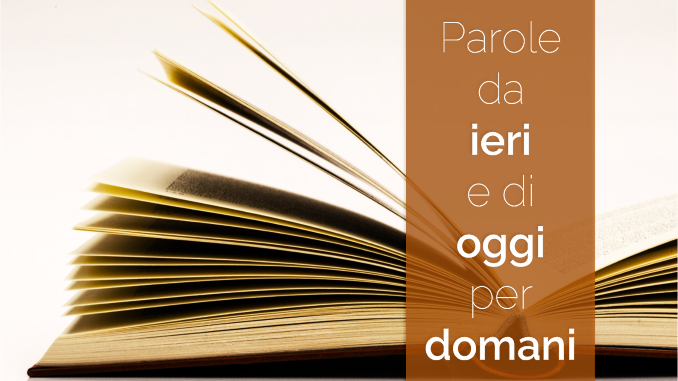Vi proponiamo ampi stralci dell’omelia del vescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, pronunciata in occasione della festa patronale di San Giminiano (Modena, 31 gennaio 2020).
Una ricetta sicura per complicarsi la vita è occuparsi degli altri. Viceversa, un segreto per vivere tranquilli è pensare a se stessi. Qualche volta noi pieghiamo addirittura il nobilissimo concetto di “pace” ad esprimere un ideale di disimpegno: “Voglio stare in pace”, “lasciatemi in pace”. Siamo arrivati a identificare la serenità con l’isolamento e il fastidio con la relazione. Ma i profeti, che hanno migliorato la storia, l’hanno fatto proprio complicandosi la vita, rifiutando la falsa pace dell’indifferenza e giocandosi per la vera pace del dono di sé. La falsa pace fa leva sull’istinto di autoconservazione; la vera pace dà voce al desiderio di relazione.
Cos’è che fa la differenza dentro di noi? Che cosa ci muove alla vera pace dell’impegno e del sacrificio anziché alla falsa pace del ripiegamento su noi stessi? Il Vangelo di oggi lo esprime con una parola, che va compresa bene: “Compassione”. Dice infatti che Gesù, “vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore”. Ciò che fa scattare in lui e negli apostoli il desiderio di curare malati e infermi è la compassione. A spingere Gesù e i discepoli verso i fratelli fragili non è dunque un’azione, ma una “passione”; com-patire significa letteralmente condividere la sofferenza. Prima che “fare qualcosa per gli altri”, è necessario “lasciarsi raggiungere dagli altri”; solo se la fragilità dell’altro mi entra nel cuore, solo se la sento mia, solo se la ospito dentro di me, posso superare l’indifferenza, posso aiutare senza mortificare, dare una mano senza puntare il dito.
In uno dei passaggi più noti di Lettera a una professoressa, scriveva don Lorenzo Milani: «Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia». È la differenza, in fondo, tra la vera pace e la falsa pace, tra la compassione e l’indifferenza.
La politica più alta prende le mosse dalla compassione, dalla condivisione dei problemi, dalla partecipazione intima alle fragilità degli altri. La politica con la “P” maiuscola, come la chiama papa Francesco, è la più alta forma di amore, perché si rivolge non solo ai vicini o a coloro che se lo meritano, ma guarda al “bene comune”, si lascia toccare il cuore dalle fragilità altrui, cerca di compensare le ingiustizie, dà la parola a chi non ha voce.
In un discorso del 1927 ai giovani della FUCI, in piena dittatura fascista, papa Pio XI disse che era necessario porre le basi «della buona, della vera, della grande politica, quella che è diretta al bene sommo e al bene comune, quella della polis, della civitas, a quel pubblico bene, che è la suprema legge a cui devono essere rivolte le attività sociali». E concludeva che il bene comune «è il campo della più vasta carità, della carità politica».
La carità politica non è quindi un optional. Fare politica, in questo senso altissimo, è dovere morale di tutti i cittadini e non solo di coloro che lavorano nelle istituzioni; e per i cristiani è un dovere fondato sul Vangelo, prima ancora che sulla coscienza e sulle leggi democratiche. Gesù ha affisso nei cuori umani un manifesto politico incisivo e concreto, direi quasi corporeo: dare da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire chi è nudo, accogliere i forestieri, visitare i carcerati e curare i malati. Il programma politico di Gesù riguarda prima di tutto le necessità materiali, ma si estende poi a quelle morali e spirituali: agli affamati e assetati di verità e giustizia, a chi è spogliato della dignità, a chi viene estraniato dal mondo di quelli che contano, a chi è privato della vita, della libertà e della salute, a chi cerca un senso alla propria esistenza, che solo la fede in Dio può rivelare.
Per fare politica con la “P” maiuscola occorre quindi partire dalla condizione di chi è ritenuto minuscolo nella società; occorre, come dice ancora il Papa, ascoltare «il grido della terra e il grido del povero» (cf. Laudato si’, 49). Un grido intrecciato, perché la custodia del creato e la custodia dei fratelli vanno di pari passo. Quando gli uomini depredano la terra, la terra grida; e quando la terra grida, gli uomini – specialmente i più deboli – soffrono, fuggono, combattono tra loro, si ammalano. Un grido che però rischia di andare perduto nel rumore di una società che sembra in balia di chi urla più forte, di chi getta invettive sul prossimo, specialmente se debole e indifeso. Il grido della terra e il grido del povero è spesso soffocato dall’indifferenza e sopraffatto dalla confusione. Per sentirlo, per distinguerlo tra le tante voci, è necessario un cuore capace di “compassione”, come quello di Gesù; è necessario un animo “politico”, in grado di aprirsi agli altri, di uscire dalla propria gabbia interiore ed entrare nelle fragilità dei fratelli. “Politico”, in questo senso, è il contrario di “monolitico”, che significa chiuso in se stesso, irrigidito come un sasso nella propria situazione.